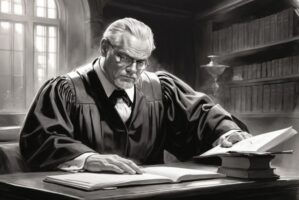Nolo solo un aumento dei dazi al 104% sulle merci importate dalla Cina. Dal 2 maggio 2025, gli Stati Uniti chiuderanno anche una delle porte più vantaggiose del commercio globale: con un ordine esecutivo firmato il 2 aprile, il presidente Donald Trump ha decretato la fine del trattamento doganale agevolato per le spedizioni di basso valore provenienti da Cina e Hong Kong.
Si tratta dell’abolizione della cosiddetta esenzione de minimis, che per anni ha permesso a milioni di pacchi contenenti abbigliamento, accessori, elettronica e altri beni di largo consumo di entrare nel Paese senza dazi e senza formalità doganali. L’agevolazione verrà sostituita da un dazio fisso: il 30% del valore del pacco, oppure 25 dollari a pezzo, a seconda di quale importo risulti maggiore. A partire dal primo giugno, il dazio minimo salirà a 50 dollari per articolo.
Il provvedimento non arriva a sorpresa. Già a febbraio, l’amministrazione Trump aveva tentato una prima attuazione della misura, sospesa dopo pochi giorni a causa dell’impreparazione dell’Agenzia delle Dogane e del servizio postale statunitense. Ma con un sistema di riscossione pronto, la stretta entrerà presto in vigore. E la Casa Bianca ha annunciato che anche altri Paesi potrebbero presto essere interessati dalla fine del de minimis, una volta che saranno completati gli adeguamenti operativi necessari.
Per capire l’impatto della decisione, occorre tornare a cos’è, in pratica, l’esenzione de minimis. Si tratta di una soglia – negli Stati Uniti fissata a 800 dollari – sotto la quale le merci importate non sono soggette a dazi doganali né richiedono particolari dichiarazioni. Questa soglia d’esenzione venne introdotta nel 1938 con lo scopo di semplificare la burocrazia ed è gradualmente aumentata nel tempo: da un solo dollaro nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, fino all’impennata del 2016, quando l’amministrazione Obama la portò dagli allora 200 agli attuali 800 dollari.
Negli anni più recenti, in particolare durante la pandemia da Covid-19, l’esenzione ha favorito l’esplosione del commercio elettronico cinese verso il mercato statunitense. Colossi digitali come Shein, Temu e AliExpress hanno costruito il loro successo proprio sfruttando questa corsia preferenziale, basata su una logistica snella: spedizioni dirette dalla fabbrica al cliente finale, senza passaggi intermedi, senza dazi, senza controlli, e soprattutto a costi molto competitivi. Secondo le stime, nel 2024 oltre quattro milioni di pacchi al giorno sono entrati negli Stati Uniti con questo meccanismo. Si parla di oltre un miliardo di spedizioni annuali, per un valore ufficiale dichiarato di circa 23 miliardi di dollari, che potrebbe in realtà superare i 40 miliardi secondo alcune analisi indipendenti.
La fine dell’esenzione rischia di causare ripercussioni a catena. Le piattaforme online, oggi basate su un modello di volumi elevati e margini minimi, dovranno cambiare radicalmente strategia. Alcune stanno già spostando parte del magazzino direttamente negli Stati Uniti, altre valutano il passaggio dal trasporto aereo – rapido ma costoso – a quello marittimo, più lento ma sostenibile sul piano tariffario. I prezzi per i consumatori americani saliranno, anche perché in molti casi le merci saranno soggette a più livelli di tassazione: i dazi precedenti al 2016, quelli della guerra commerciale con la Cina del 2018, e ora i nuovi dazi imposti con l’abolizione del de minimis. Uno studio della Yale University stima che le famiglie statunitensi potrebbero spendere tra i 136 e i 163 dollari in più all’anno, con un impatto maggiore per le fasce a basso reddito, che sono anche le più attente al risparmio e più affezionate a queste piattaforme.
Anche la logistica globale si prepara a una trasformazione. Il trasporto aereo – in particolare quello cargo sulle rotte transpacifiche – potrà subire un contraccolpo rilevante. Gli analisti stimano un calo del 60% nella domanda legata al commercio elettronico cinese. Meno pacchi significa meno voli e tariffe in discesa. Un danno per i vettori aerei, ma forse un’opportunità per alcuni operatori consolidati, come le multinazionali dell’espresso aereo, che offrono servizi avanzati di gestione doganale e vedono nella nuova complessità una possibile leva competitiva.
Alla base della decisione non ci sono solo motivazioni economiche. La Casa Bianca ha giustificato la misura anche con la necessità di aumentare i controlli doganali, contrastare l’importazione di sostanze stupefacenti come il fentanyl – spesso nascoste proprio nei pacchi de minimis – e fermare le spedizioni provenienti da aree coinvolte in violazioni dei diritti umani. Si tratta, insomma, di una misura che unisce protezionismo commerciale e sicurezza nazionale, e che ridefinisce gli equilibri del commercio globale.
Anche se l’impatto diretto sul Pil americano sarà marginale – le spedizioni de minimis rappresentano solo una piccola frazione dei 5,3 trilioni di dollari in importazioni annuali – le conseguenze sistemiche potranno essere molto più profonde. Il modello del commercio elettronico e globale, nato sulla spinta di costi marginali bassi e flussi incontrollati di piccole spedizioni, entra ora in una fase nuova, fatta di dazi, tracciabilità, conformità e ristrutturazione delle catene di approvvigionamento.